[Un estratto dal mio: Perché il reale, eternamente, Delos Digital, 2023. ]
* * *
Il 15 settembre 1999, il quarantasettenne Larry Gene Ashbrook, armato di tutto punto, entra in una chiesa battista di Fort Worth, popolosa città texana, e vi uccide sette persone, tra cui quattro adolescenti, ferendone altrettante e suicidandosi prima dell’intervento della polizia. Sul quotidiano italiano la Repubblica, due giorni dopo, il giornalista Vittorio Zucconi scriveva: «Doveva essersi svegliato proprio male quella mattina, il nostro bravo Larry, a giudicare da quello che la polizia ha trovato nella sua casa, dopo la strage. Le pareti erano butterate di colpi di piccone e di proiettili, le porte sfondate, i vetri infranti, i mobili sfasciati e sparpagliati, i divani sventrati e la tazza del water otturata per sempre da una colata di cemento, come se il tornado Larry, dopo avere devastato la sua casa, avesse voluto assicurarsi che dopo di lui nessuno potesse servirsi del suo gabinetto. Anche il cesso ha dovuto morire con lui»[1].

Ora, non sapremo mai perché Ashbrook ce l’avesse con Dio e con i suoi servi – ognuno può avere al riguardo delle buone o pessime ragioni – né tanto meno possiamo farci un’idea plausibile del motivo che lo abbia spinto a commettere una strage. Parlare di “follia”, in questi casi, mette a tacere le nostre paure, maschera l’inspiegabile, lo estromette dal nostro territorio, dalla nostra “normalità”, ma non ci evita, alla lunga, una labilità, una flagrante e generale inadeguatezza nel saper contornare (e recintare efficacemente) gli eccessi e le sfrenatezze del comportamento umano.
Nel caso di Larry, a ogni modo, si può azzardare un’interpretazione topologica verosimile del perché egli abbia distrutto la propria casa e cementato la tazza del cesso: non prevedendo di tornar vivo da quella che era la sua personalissima guerra, ha voluto impedire che altri s’installassero comodamente nella sua “tana” e defecassero nel suo territorio. Allo stesso tempo, ha fatto sì che le proprie tracce fossero coperte, confuse, inattingibili. In un modo pressoché animale, e che presenta comunque un che di derisorio e sovrano, ha cercato (quanto illogicamente?) di realizzare un distacco “mostruoso” (oserei dire: a-teologico) rispetto agli spazi occupati dall’umano.
Non credo peraltro che Larry avesse davvero una causa per giustificare la sua guerra contro l’umanità. Di certo, non aveva una causa condivisibile, né probabilmente la cercava. In qualche modo insondabile, era preso da tutte le cause. Anzi, erano state tutte le cause dell’umanità ad aver preso lui. Ashbrook decide dunque di fare qualcosa d’irrimediabile per uccidere il dovere, e così uccide in sé le differenze o le troppe similitudini col resto d’un mondo che ormai egli odiava a morte. Chissà, forse non poteva più tollerare di essere intollerante nei confronti di una conformità sociale incline alla tolleranza. Il labirinto dei giorni lo stava annichilendo. Doveva quindi darsi una causa che uccidesse ogni altra causa, in modo da produrre degli effetti del tutto fini a se stessi, che cioè fossero chiari, non recuperabili, inutili, e più essenziali di qualsiasi causa.
In alcune pagine della terza parte della pentalogia 2666 di Roberto Bolaño, compare il cosiddetto Penitente[2]. Insozzatore di chiese e uccisore casuale di sacrestani e figure simili, il personaggio in questione presenta qualche punto di tangenza con Ashbrook, ma in negativo rispettivo a quest’ultimo. Laddove Larry occlude all’Altro ogni canale di scolo, arrivando a cementare la tazza del proprio cesso, in modo da bloccare definitivamente l’invasione fecale e ferale dell’esterno, del “fuori”, il Penitente occupa coi suoi umori i luoghi della sacralità e li impregna, li impegna, li assedia inutilmente con la propria torrenziale mancanza di causa.
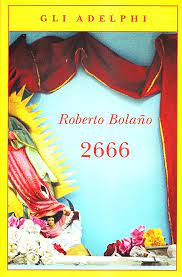
Il suo orinare nelle chiese non è una mera marcatura territoriale. Non vuole farsene abitante, non ne espropria il senso, ma ne sottolinea, se mai, suo malgrado, la falsa igiene morale, nonché il tradimento di ogni materialità, di ogni tracimazione del vivente.
Bolaño lo tratteggia con non poca simpatia. Potremmo quasi dire che ne faccia il vettore di un’impudicizia mitologica, di una sporcizia senza limiti che nega sia la tradizione, sia il tradimento moderno della tradizione. Il Penitente piscia, ammazza, ma non prende partito, non ha neanche una voce. Si arroga un dispiegamento, un ruscellamento, non una spiegazione. Non è un caso, infatti, che scompaia poi nel nulla. Non viene acciuffato. Non si sa che fine faccia. Sparisce senza lasciare alcun valore. Viene semplicemente espunto dalla narrazione. In qualche modo, appare per dire la perversione del sacro e della stessa scrittura che contorna vanamente i recinti sacri del letterario. Se la scrittura è una sorta di pisciata dello spirito, il Penitente, allora, è il dadaista compiuto, il situazionista senza racket ideologico.
[1]Vittorio Zucconi, Fuoco sui ragazzi del coro, “la Repubblica”, 17 settembre 1999.
[2]Roberto Bolaño, 2666, Adelphi, Milano, 2009, pp. 393-415.
